Molti e molto diversificati sono i modi in cui un paziente può reagire ad una diagnosi oncologica o alla conseguente malattia all’iter terapeutico. Ogni persona è unica e diversa dalle altre e ogni persona può reagire in modo soggettivo. Questo tuttavia non ha ostacolato gli studiosi nel tentativo di classificare e descrivere le più comuni reazioni dei pazienti in questi momenti delicati della loro vita. Si distinguono due gruppi di risposte psicologico-emozionali nei pazienti, relazionate al momento della comparsa e alla eventualità che questi rimangano nel tempo e mutino in sindromi psicologiche qualora non vengano adeguatamente prese a carico.
Il primo momento critico, come è naturale che sia, è quello che il paziente deve affrontare alla diagnosi. Questo segna il passaggio da non essere paziente al diventarlo, da non essere malato ad esserlo, dal non rischiare la vita al sentirsi improvvisamente una spada di Damocle pendente sul capo. Questo può essere non solo un grande scossone, o una notizia da digerire, ma può essere un vero e proprio mettere in dubbio la propria persona in relazione ai vari compiti o ruoli che il paziente ha nella società e nella famiglia. Sembra frequente l’incasellamento nella categoria “malato di cancro” con tutto ciò che l’immaginario collettivo porta con sé relativamente ad una visione riduttivistica e limitante della persona malata. La persona a volte tende a percepirsi non più come persona investita di vari ruoli e capacità ma è portata a considerarsi solo un malato in virtù del fatto di avere una malattia e una malattia tra le peggiori. Questo ovviamente non accade sempre e non accade sempre nello stesso modo o comunque può accadere in maniera anche molto sfumata e subdola. Tutto ciò si può anche considerare una risposta normale sempre e solo nella misura in cui questo non cronicizzi. Le risposte che si considerano naturali in genere compaiono alla diagnosi e si protraggono per circa dieci giorni e ci si aspetta che si risolvano nell’arco di un paio di settimane. In particolare, si presenta ovviamente uno shock iniziale dato dalla notizia diagnostica abbinata a sentimenti di incredulità e stordimento. Il paziente non riesce sempre a capire e comprendere in toto cosa gli sta accadendo e riferisce spesso di sentirsi stordito dalle notizie che ha ricevuto. Si sente racchiuso in una sorta di “bolla di sapone” dove tutte le cose ruotano attorno a sé alla rinfusa. Di li viene una graduale comprensione della realtà. Compare una sorta di sedimentazione, risoluzione di dubbi, una sorta di accettazione mista a rassegnazione. Questa fase è sovente accompagnata da sentimenti di disperazione e scoramento che possono a volte virare, soprattutto in famiglia e in presenza delle persone di fiducia del paziente, in sintomi misti quali disforia o irritabilità, umore depresso o al contrario euforico. Molti pazienti manifestano atteggiamenti di difficoltà di concentrazione o mancanza di energia nello svolgimento delle normali attività quotidiane. Spesso è presente anche un senso di spossatezza verosimilmente correlato anche a difficoltà nel prendere sonno e alla perdita di appetito. Anche il sonno è descritto come spesso interrotto o disturbato da pensieri o sogni intrusivi. Tali pensieri e paure continuano a occupare la mente del paziente anche lungo la giornata, sia nei momenti di riposo ma anche durante le attività che spesso non riescono a tenere la persona lontana dal tornare con il pensiero a quanto le sta accadendo.
Tutte queste risposte e questi atteggiamenti sintomatici descritti in letteratura sono considerati la naturale conseguenza di una notizia di portata importante e con grande potenziale distruttivo che ne giustifica a pieno la comparsa anche in persone non naturalmente inclini a difficoltà di ordine psicologico, caratteriale o emozionale. Come anticipato sopra ci si aspetta che questi sintomi, qualora presenti, vadano scemando nell’arco di circa quindici giorni.
Diversa naturalmente è la situazione in cui questi sintomi cronicizzino senza essere risolti e volgano al peggioramento o ancora diversa è la situazione in cui si sviluppi una vera e propria sindrome psicopatologica.
Anche nel caso delle sindromi psicopatologiche, non è sempre chiaro quali siano le principali, soprattutto perché non è sempre semplice correlarle in modo sicuro alla comparsa della malattia neoplastica. La presenza di una sindrome psicopatologica in concomitanza di una diagnosi di cancro non permette sempre di stabilire una oggettiva relazione di causalità tra comparsa della malattia neoplastica e sviluppo o aggravamento della sindrome stessa. Le principali sindromi descritte sono diverse e sono diverse soprattutto in relazione alle tipologie di cancro, di pazienti e di situazioni socioculturali (un cancro al seno diagnosticato in occidente non ha lo stesso impatto di un cancro al seno in una donna indiana). Si possono sintetizzare cinque sindromi principali da relazionarsi con il cancro: disturbi dell’adattamento, disturbi d’ansia, disturbi depressivi, disturbi della sfera sessuale e disturbi psichiatrici su base organica. (Grassi L, Biondi M, Costantini A, Manuale pratico di psico-oncologia, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2003.)
- I disturbi dell’adattamento rappresentano una condizione psicologica intermedia tra le normali risposte emotive e i sintomi di un disturbo psichico maggiore. Sono caratterizzati dalla presenza di sintomi affettivi o comportamentali clinicamente evidenti in risposta ad uno stressor. Si caratterizzano per la presenza di comportamenti non adattivi in una o più aree psicosociali quali le relazioni, il lavoro, gli interessi in associazione con ansia e depressione. Questo genere di sintomi viene normalmente superato entro i sei mesi.
- I disturbi d’ansia rappresentano reazioni alla minaccia posta dal cancro e dal suo trattamento; essi sono caratterizzati da sintomi primari somatici quali aumento della frequenza cardiaca, respiro affannoso, sudorazione, vertigine, parestesie, nausea, difficoltà a concentrarsi, irritabilità e sintomi cognitivi come la paura di perdere il controllo o di impazzire o di morire, sentimenti di irrealtà pensieri catastrofici e la costante tendenza al rimugino. Sono descritti anche possibili attacchi di panico.
A proposito dei disturbi depressivi è importante distinguerli da fatigue (tipico effetto collaterale delle terapie con farmaci antineoplastici) e demoralizzazione.
I sintomi primari sono rappresentati da abbassamento del tono dell’umore, perdita di interesse e di piacere nel fare le cose, perdita di valore in sé stessi, sensi di colpa, disperazione, perdita dell’energia, diminuita capacità di attenzione e concentrazione, ricorrenti pensieri di morte, variazione del peso, disturbi del sonno. Sono spesso associati alla presenza di ansia e anche per questa ragione l’individuazione di tale sintomatologia risulta non facile.
I disturbi della sessualità invece vanno ben contestualizzati riguardo a dei fattori di rischio ben specifici. Questi fattori di rischio si sono rivelati spesso alla base dello sviluppo di problemi legati alla sfera sessuale e si è visto che agendo, ove possibile, su questi si abbassa l’eventualità di comparsa dei disturbi sessuali.
In particolare, la giovane età, difficoltà sessuali pregresse, particolari caratteristiche relazionali della coppia, la localizzazione della malattia e il suo stadio e il tipo di piano terapeutico sono certamente dei fattori che giocano un ruolo principe nel predisporre un fertile terreno di sviluppo delle disfunzioni della sfera sessuale.
I pazienti si trovano a confrontarsi spesso con disturbi del desiderio (calo della libido o evitamento sessuale), disturbi dell’eccitamento come difficoltà erettili nel maschio o secchezza vaginale nella donna, disturbi dell’orgasmo (anorgasmia o eiaculazione precoce o tardiva) e anche disturbi del dolore nell’atto della penetrazione oppure in condizioni non legate al rapporto sessuale (dispareunia e vaginismo).
Un caso del tutto particolare è quello dei disturbi psichiatrici su base organica e si presentano in genere in relazione al tipo di malattia, alla sua sede o alla sede delle metastasi che la stessa sviluppa. Questo tipo di disturbi sono di primaria rilevanza in pazienti con cancro in stadio avanzato. La prevalenza (compresa tra il 5 ed il 40%) aumenta anche a seconda dello stadio di sviluppo della malattia e delle terapie effettuate. Spesso sono determinati da una sofferenza del Sistema Nervoso Centrale: metastasi cerebrali, processi infettivi, disturbi del metabolismo, chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di terapie farmacologiche, ecc. Possono essere caratterizzati da disturbi della attenzione, della memoria, del comportamento, del pensiero, psicomotori e da alterazioni del ciclo sonno-veglia.
Si è cercato molto di raggruppare le difficoltà psicologiche, sociali e spirituali vissute dai pazienti oncologici per poterle anche misurare e di conseguenza prendere in carico. Il termine che in genere viene usato in questo senso in oncologia è distress. La psico-oncologia si avvale di una definizione ben specifica di questo termine risalente al 2003 e coniata dal National Comprehensive Cancer Center che definisce il distress in campo oncologico come tutte quelle spiacevoli esperienze emotive di natura psicologica, sociale e/o spirituale che si estende lungo un continuum che va da normali sentimenti di vulnerabilità, tristezza e paura, a problemi invalidanti quali la depressione, l’ansia, il panico, l’isolamento sociale o la crisi spirituale.
L’oncologia ha creato anche uno strumento di misurazione del distress che si pone l’obiettivo non solo di rilevarlo ma anche e soprattutto di monitorarlo nel tempo della malattia e della cura in modo da poter attivare eventualmente i sostegni necessari.
Questo strumento si basa sullo studio di alcuni fattori di rischio quali storia psichiatrica, tipologia e sede del cancro, prognosi negativa, giovane età, basso reddito, difficoltà comunicative e scarso supporto sociale per definire dei parametri per il rilevamento del distress e dei conseguenti livelli di gravità: possiamo dire che i disturbi che si riscontrano al di sotto del livello cinque sono considerati non gravi e normali e comprendono paure, preoccupazioni ed incertezze, sentimenti di tristezza, di rabbia o di perdita di controllo, difficoltà del sonno e riduzione dell’appetito, problemi di concentrazione e pensieri ricorrenti rispetto alla malattia o alla morte. Il rilevamento del distress del paziente oncologico è stato una grande conquista e un grande aiuto. Ha generato svariate conseguenze positive ed effetti benefici derivanti dallo screening e dal riconoscimento del distress stesso consentendo di:
- Favorire l’apertura del dialogo tra paziente e curante
- Evidenziare elementi di disagio non riportati a nessuno
- Identificare i pazienti con reale bisogno di aiuto
- Ricercare l’effettiva relazione del disagio con il cancro
- Aumentare la soddisfazione dei pazienti rispetto alle cure
- Migliorare la comunicazione e la fiducia nella relazione con paziente
- Diminuire le telefonate e le richieste di visite determinate dalla preoccupazione ed ansie del paziente
- Migliore comprensione dei trattamenti e migliore compliance
- Migliorare gli esiti del trattamento
- Decrementare la prevalenza dei disturbi psicologici più gravi
- Abbassare la presenza di disagio e burn-out tra il personale
Si è ritenuta importante questa digressione sui principali disturbi psicologici relazionati al cancro per contestualizzare maggiormente il tema e permettere una comprensione più piena e completa dell’impatto psicologico al quale il paziente oncologico può andare in contro e di come si possa agire a sostegno tramite l’utilizzo della psicoterapia ipnotica.
Questo articolo non vanta pretese di esaustività o completezza ma si pone invece solamente lo scopo di divulgare la conoscenza relativa ai campi d’azione della psicoterapia ipnotica e stimolare gli addetti ai lavori all’applicazione della materia clinica per creare benessere nel paziente ma anche per creare nuova casistica e quindi nuova conoscenza e scienza.
Nella letteratura scientifica non è presente un cospicuo numero di studi che trattino specificamente l’utilizzo dell’ipnosi nella presa a carico dei disturbi dell’adattamento, probabilmente perché in oncologia la diagnosi di questo disturbo secondo i criteri del DSM V risulta a volte transitoria (già per la natura stessa del disturbo) e difficoltosa e quindi non adeguatamente rappresentata o spesso assente. Per quanto riguarda la mia esperienza, una caratteristica importante che possa giustificare l’assenza di questa diagnosi è la modalità stessa con cui il paziente viene a conoscenza della sua malattia che è costellata di esami, dubbi, smentite e conferme. Quando il paziente ha la certezza della diagnosi viene travolto da una enorme quantità di informazioni legate all’iter terapeutico che lo aspetta e agli esami, (altri, ulteriori e nuovi) che deve affrontare per accedere alle terapie in modo sicuro. Inizia poi la terapia che occupa gran parte delle energie del paziente e in tutto questo, il tempo per diagnosticare un disturbo transitorio se non è già passato non è per lo meno sufficiente per consentirne l’osservazione della manifestazione da parte di un professionista della salute mentale che spesso, se riesce ad approcciarsi a questo tipo di paziente, lo accoglie in uno stato già avanzato in cui la fisiologia psichica sta già mettendo in campo dei meccanismi di protezione e reazione.
Va precisato e sottolineato che la difficoltà di reperimento di letteratura pertinente non rispecchia in alcun modo l’ipotesi che tale disturbo non sia presente in paziente portatore di patologia neoplastica. Una meta-analisi pubblicata nel febbraio 2011 su “Lancet. Oncology da Alex J Mitchell e colleghi (Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies) individua infatti la prevalenza di questa diagnosi, non associata ad altre turbe psicologiche, (secondo i criteri del DSMV) in misura del 15,4% su un campione adeguatamente rappresentativo di pazienti onco-ematologici e palliativi. Esistono in quantità generosa pubblicazioni di “letteratura grigia” a proposito di questa tematica che sostengono la validità della psicoterapia ipnotica su base empirica: sembra quindi condivisibile che vi siano dei vantaggi clinici obiettivi in termini di outcomes e in termini di “approcciabilità” indiretta del paziente: la suggestione ipnotica per mezzo di metafore e narrazioni, secondo le modalità di Erickson, permettono un approccio dolce che non solleva le resistenze del paziente. Il paziente può vivere così una esperienza di confronto con il terapeuta che non lo metta direttamente a contatto o confronto con le sue difficoltà con conseguente scantonamento della paura del giudizio o del trauma di entrare nelle proprie paure. Questa modalità appare certamente accogliente e accettante nell’esperienza del paziente. Non rappresenta forse questa una prerogativa essenziale nella costruzione del rapport adeguato che possa oliare l’ingranaggio di una psicoterapia di qualità, con maggiore garanzia di successo e di economia temporale? L’accesso a questa condizione è facilitato dall’approccio ipnotico che consente primariamente un incipit terapeutico e quindi un accostamento alla tecnica da parte del paziente, fondato sulla possibilità/necessità di rilassamento. La calma e la serenità sperimentata dal paziente in trance risulta essere immediatamente, nel vissuto del paziente, un’oasi salvifica di discontinuità in una realtà costellata di tensione e sofferenza figlia di episodi devastanti (quale una diagnosi oncologica) che caratterizzano il suo oggi.
Per quanto riguarda invece la casistica relativa ai pazienti con disturbo d’ansia, la letteratura sembra essere più generosa e maggiormente focalizzata.
A questo proposito ritengo interessante citare una meta-analisi condotta nel 2017 intitolata The effect of Hypnosis on Anxiety in Patients With Cancer: A Meta-Analysis. Questa revisione di letteratura si proponeva di sintetizzare gli effetti immediati e mantenuti nel tempo dell’ipnosi o dell’ipnoterapia in pazienti neoplastici affetti da disturbo d’ansia e di identificare e isolare le variabili responsabili di tali effetti. Pei-Ying Chen e i suoi collaboratori, autori di questo lavoro, hanno operato in banche date scientifiche isolando 20 studi clinici, principalmente studi randomizzati controllati, e operando delle analisi statistiche sugli outcomes.
I risultati del loro lavoro evidenziano che l’ipnosi e l’ipnoterapia hanno un impatto importante, statisticamente significativo, per un beneficio immediato a livello sintomatologico e sottolineano che tali effetti vantano una durata nel tempo. Essi concludono inoltre che gli effetti prodotti da una ipnosi eteroindotta sono maggiormente validi rispetto a quelli dell’autoipnosi. La letteratura in generale incoraggia l’espansione e lo sviluppo delle tecniche ipnotiche in pazienti ansiosi in virtù dei promettenti risultati già sperimentati anche in campo pediatrico dove sembra essere addirittura maggiormente performante se rapportata alla popolazione adulta.
Per non perdere la base scientifica delle mie affermazioni, non posso non ribadire che anche per quanto riguarda i disturbi dell’umore e soprattutto e in modo peculiare per la depressione, l’ipnosi rappresenta un trattamento di elezione. Questo è ampiamente documentato soprattutto guardando all’ipnoterapia nell’ordine della ristrutturazione delle credenze personali che stanno alla base del vissuto disfunzionale dei pazienti affetti da depressione. La depressione, nelle sue dinamiche e nella sua manifestazione non fa eccezione in un paziente in cui il suo stato di sofferenza emotiva e psicologica, trovi la sua causa, o quanto meno l’elemento slatentizzante in una diagnosi oncologica.
L’induzione di trance e la suggestione di metafore e dinamiche immaginifiche nella persona, sul piano biochimico e fisiologico hanno la capacità di stimolare la produzione di endorfine con un conseguente stato di benessere immediatamente percepibile dal paziente e quindi di loro natura predisponenti al lavoro psicologico e alla costruzione del rapport. Questa condizione, ripetuta e protratta diventa fondante per la persona al fine di riuscire a superare la paura dell’insight. Il soggetto è condotto all’acquisizione del riconoscimento e dell’esternazione dei propri vissuti di rabbia e aggressività fini prima ritenuti inaccettabili o perentoriamente negati (Miller, Gruber e Yapko (1999), The Hypnotic Treatment of Depression, Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine).
Trovo intellettualmente onesto affermare che l’ipnosi possa permettere al paziente di riappropriarsi, in questo senso, del suo diritto di autoguarigione e autodeterminazione. Prendere in mano la propria vita e rinsaldare la presa sul timone ricostruendo e mantenendo la convinzione di saper dirigere l’imbarcazione della propria storia rappresenta, a mio avviso, il visto d’uscita dalle acque del disturbo depressivo.
L’accompagnamento psicologico di un paziente con diagnosi neoplastica è molto complesso sotto vari punti di vista. La vita affettiva e sessuale della persona non di rado viene travolta dagli eventi, imbottita di mille altre dinamiche che di tutto sanno fuorché di normalità.
Sappiamo quanto il tema dell’affettività e della sessualità possano essere legati e interdipendenti.
Le difficoltà sessuali in questi pazienti possono avere un’eziologia variegata e possono avere una caratterizzazione organica (pensiamo a interventi chirurgici adiuvanti o neoadiuvanti) in cui una parte del corpo come il seno o i testicoli possono essere asportati totalmente o parzialmente.
Sempre sul piano organico possiamo trovare gli effetti collaterali dei trattamenti con citostatici ma anche farmaci di nuova generazione come anticorpi monoclonali o inibitori o modulatori enzimatici (turbe ormonali, impotenza, minaccia alla possibilità di riprodursi).
Altro filone eziologico è invece rappresentato da quei disturbi della sfera sessuale con una caratterizzazione preponderante di tipo psicologico come risultato dell’esperienza “cancro” (comprensiva di trauma della diagnosi, rielaborazione, adattamento all’iter terapeutico, alterazione dell’immagine corporea, minaccia di vita ecc..) che il paziente si trova a vivere.
Sono convinto che, anche se con metodiche, livelli di efficacia e obiettivi differenziati, lo psicoterapeuta che abbia nella sua cassetta degli attrezzi l’ipnosi, possa andare ad interagire su questi disturbi, sia che siano su base organica, sia che siano di matrice psicologica.
Non è possibile fare qui una trattazione sul ventaglio completo dei disturbi sessuali ma ritengo tuttavia che alcuni esempi possano rendere merito alle precedenti affermazioni.
Gli addetti ai lavori oncologici ben sanno che un effetto collaterale di alcune terapie riservate principalmente alla donna affetta da neoplasia mammaria, faccio riferimento all’ormonoterapia, è la vampata di calore: le donne in trattamento con questi farmaci (anche per una durata di anni) si trovano sovente a fare i conti con questi colpi di calore improvvisi seguiti da sudorazione profusa e visibile, non prevedibili e che arrecano, oltre che discomfort, imbarazzo ed esperienze quotidiane di tipo invalidante. Questa esemplificazione rientra nel primo gruppo eziologico di cui sopra e un recente case report intitolato “Hypnosis for Hot Flashes and Associated Symptoms in Women with Breast Cancer e pubblicato in ottobre 2017 in “The American Journal of Clinical Hypnosis” mette in evidenza come i meccanismi ipnotici siano stati benefici nella gestione delle vampate da parte di queste donne. Per restare sul tema racconto brevemente un episodio della mia esperienza clinica in oncologia: presi in carico un giorno un paziente affetto da carcinoma polmonare che, seguendo l’iter terapeutico completo e in modo assolutamente “compliante” di percorso (chemioterapia e radioterapia panencefalica) vantava una buona prognosi. Iniziammo l’iter terapeutico e il paziente si concentrò in maniera così peculiare e esclusiva sul suo percorso di cura che si sganciò da tutta una serie di suoi altri bisogni. Improvvisamente lamentò una disfunzione erettile e chiese un sostegno farmacologico al suo medico per poter condurre una vita sessuale appagante. Era solito parlare della sua problematica in maniera tanto imbarazzata quanto goliardica descrivendo il suo disagio come se “si fosse dimenticato come si fa per tirare su la bandiera” e di fatto riferiva di non riuscire ad avere una adeguata erezione nemmeno in situazioni fortemente predisponenti. In quel senso lui si definiva un “mezzo uomo”. Possiamo facilmente immaginare le ricadute di tutto questo nella sia vita affettiva di coppia e in famiglia. Da precisare che i trattamenti che lui assumeva non potevano dare origine ad una problematica di quest’ordine.
Quello però che interessa è che questo paziente aveva già fornito una metafora pronta all’uso per un terapeuta, aveva un impianto privilegiato sul sistema rappresentazionale visivo e quindi, probabilmente, una predisposizione immaginifica favorente. Non si fece ipnosi a questo paziente, purtroppo. Va precisato, per esempio, che la tematica era già presente in letteratura. Basti pensare che nel 1997, S. Aydin, aveva pubblicato uno studio caso-controllo nello “Scandinavian Journal of Urology and Nephrology” il quale concludeva che il 75% dei pazienti affetti da disfunzione erettile (di ordine non organico) aveva risolto i sintomi attraverso l’uso dell’ipnosi. Lo studio era condotto portando a confronto ipnosi/placebo e agopuntura/placebo. Solo l’ipnosi ha dato dei risultati statisticamente significativi rispetto al trattamento placebo.
Per quanto riguarda i disturbi su base organica, risulta chiaro che l’ipnosi, come gli altri approcci psicoterapeutici, poco può operare con la sintomatologia che da essi deriva. Rimane però sempre un supporto fondamentale per tutte le disfunzioni e i disequilibri psico-emotivi che da questi disturbi prendono forma con ottica di consequenzialità. Qui possiamo trovare manifestazioni come angoscia, depressione ansia e tutte le problematiche che possono investire una persona che improvvisamente si trova a convivere con delle funzioni (cognitive, percettive, motorie, affettive…) che gli sfuggono di mano e che non rispondono più al proprio controllo e invalidano, talvolta in maniera profonda e sferzante la vita della persona e la sua esistenza.
Per avviare al termine questo articolo e dopo il percorso che ho cercato di fare scrivendo questo testo mi sento di rinforzare l’opinione dell’utilità della psicoterapia ipnotica in oncologia. Quanto ho solo accennato nel testo, ha un grande margine di approfondimento a livello di conoscenza ma soprattutto ha un campo aperto in termini empirici. Come abbiamo visto forse in questo campo la letteratura scientifica non è così fiorente ma le prerogative sono buone e promettenti.
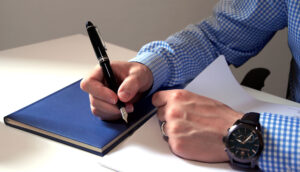
Mi piace concludere questo articolo incoraggiando gli psicoterapeuti a sostenere i pazienti oncologici e a lavorare con loro: per loro si può fare molto e anche se a noi sembra poco, per loro è davvero tanto. Barbara Ehrenreich sintetizza magistralmente l’obiettivo celato di questo articolo con una frase diventata ormai celebre: “L’incapacità di pensare in positivo può pesare su un malato di cancro come una seconda malattia.” Buon lavoro!
Bibliografia:
Miller, Gruber, Yapko (1999) “The Hypnotic Treatment of Depression”. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine October 1999 vol. 5 no. 2 151-162.
Alex J Mitchell et al., (2011) “Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies”. Lancet Oncology 2011, Feb;12(2):160-74
Yapko M., (2001) “Hypnosis in treating symptoms and risk factors of major depression”. The American Journal of Clinical Hypnosis 2001 Oct;44(2):97-108.
Aydin S et al., (1997) “Acupuncture and hypnotic suggestions in the treatment of non-organic male sexual dysfunction”. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 1997 Jun;31(3):271-4.
